Il patto del mattone
 Come era facilmente prevedibile, la notizia sulla scarsa valorizzazioni di case, negozi e palazzi di proprietà del Comune è rimasta solo notizia. Discussione in Commissione consiliare da parte dei partiti presenti in Comune, numeri sommari da un inventario patrimoniale altrettanto sommario, poi basta. …
Come era facilmente prevedibile, la notizia sulla scarsa valorizzazioni di case, negozi e palazzi di proprietà del Comune è rimasta solo notizia. Discussione in Commissione consiliare da parte dei partiti presenti in Comune, numeri sommari da un inventario patrimoniale altrettanto sommario, poi basta. …
Una prima condizione comporta l’abbandono (temporaneo) della pratica della critica su ciò che è stato fatto o non fatto a favore di un atteggiamento costruens. E’ evidente che ci sarebbe da stigmatizzare scelte come quelle dell’acquisto di Villa Salus, voluta da un Sindaco che ha amministrato Bologna a dispetto dei tanti cittadini e per dispetto ai suoi compagni di partito. Ma lo sfogo non risolve il problema.
La seconda condizione, riguarda l’atteggiamento del Comune verso la dismissione o l’uso da parte di terzi del proprio patrimonio immobiliare. E’ vero, come ha detto Nomisma, che in Comune c’è una “chiara volontà di autosufficienza” nella gestione del proprio tesoretto. Solo che, nel corso del tempo, una parte di questo si è trasformato in bigiotteria per colpa di un atteggiamento da “latifondista” urbano, secondo cui meglio un bene pubblico inutilizzato ed in via di degrado che privatizzarlo o cederlo in uso a soggetti singoli o collettivi.
Bene, anzi male: oggi tutta questa “roba” va in malora, le condizioni economiche del Comune per valorizzare i propri beni sono nulle o limitate e se “Sparta (il Comune) piange, Atene (i privati) non ride”.
Mi permetto, allora, di avanzare una proposta, neanche tanto provocatoria, con la speranza che faccia discutere ma, soprattutto, muovere quel “fare” dei bolognesi e del loro modo di auto organizzarsi, sopito dalla indifferenza pubblica ma non scomparso.
Dai dati resi pubblici, si possono individuare due categorie di beni nella disponibilità del Comune: quelli alienabili e quelli da concedere in uso. Non c’è una terza categoria di beni – quelli da mettere a reddito – perché non appartiene all’amministrazione civica: se non è un buon amministratore di ciò che usa, provate a pensare se può esserlo come “padrone di casa”.
Sull’alienazione, senza voler fare i giacobini, si possono mettere in vendita tutti quei beni che hanno una destinazione commerciale (vedi i negozi di Ugo Bassi o Galleria Cavour) offrendo un diritto di prelazione a chi li occupa attualmente ed una modalità di pagamento rateale, perché le condizioni del commercio non permettono, oggi, investimenti consistenti sui locali dove si lavora.
Per quelle, invece, di destinazione residenziale o i grandi complessi (come Villa Salus o Villa Ghigi), si possono vendere sulla base di una proposta irrevocabile di acquisto che renda evidente, da un lato il prezzo e dall’altro, la destinazione che di quel bene si vuole chiedere. Si provi ad invertire, per una volta, la regola per cui l’Ente pubblico stabilisce già cosa fare: l’esempio dell’alienazione, parziale e insoddisfacente, delle caserme dismesse è sufficiente per non insistere. In questo caso, il Comune decide alla luce del sole ed in regime di assoluta pubblicità, qual è la soluzione più conveniente, non solo economicamente ma anche in rapporto al futuro uso che di quel bene verrà fatto.
Diverso discorso, invece, per i beni che il Comune non può o non deve vendere. Ci sono immobili pubblici inagibili, degradati o da ristrutturare. Ci sono tante organizzazioni o forme di autorganizzazione della comunità bolognese che cercano luoghi in cui trovarsi e sviluppare le proprie attività. Possibile che le due situazioni non possano trovare un reciproco vantaggio nel collegarsi tra loro? Ciò che si pagherebbe come canone locatizio potrebbe essere convertito in spesa per risistemare gli immobili comunali: si agevolerebbe la naturale predisposizione alla socialità dei bolognesi aumentando il valore economico di un patrimonio ristrutturato. Una comunicazione diffusa con la pubblicazione delle piante catastali e di foto dei luoghi rappresentative del loro stato; un sopralluogo con indicazioni di massima sui lavori indifferibili; la presentazione di progetti di riqualificazione ed uso degli spazi per un periodo sufficiente a “rientrare” della spesa sostenuta. Non è una ricetta originale né velleitaria: è una riedizione aggiornata di quel “patto” che ha contrassegnato per lungo tempo il rapporto tra un Comune delle opportunità e la sua comunità desiderosa di autorganizzare la propria partecipazione.
Roberto Dalle Nogare


 MEMORIAL “LUCIANO DEBIASI” 2019 – TORNEO INTERNAZIONALE DI LOTTA GR – Si è disputato al Palasport di Rovereto la coppa Italia 2019 di Lotta olimpica che ha visto la partecipazione di quasi trecento lottatori.
MEMORIAL “LUCIANO DEBIASI” 2019 – TORNEO INTERNAZIONALE DI LOTTA GR – Si è disputato al Palasport di Rovereto la coppa Italia 2019 di Lotta olimpica che ha visto la partecipazione di quasi trecento lottatori.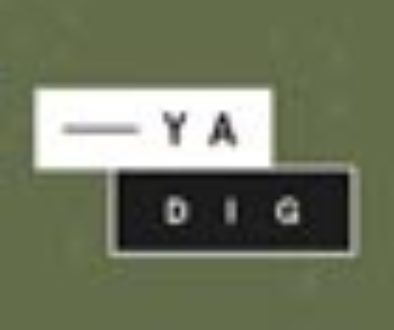
 STUDIO 54 – Sabato 23 novembre dalle ore 23:30 – evento riservato ai soci AICS
STUDIO 54 – Sabato 23 novembre dalle ore 23:30 – evento riservato ai soci AICS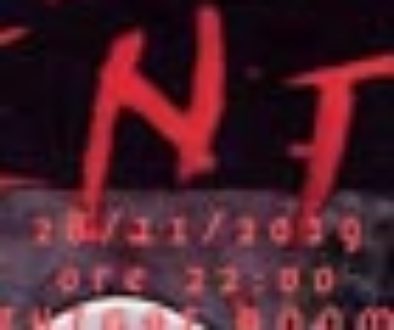
 IKIGAI ROOM BOLOGNA – Giovedì 28 novembre dalle ore 22:00 – Proiezione gratuita riservata ai soci AICS 2019/20
IKIGAI ROOM BOLOGNA – Giovedì 28 novembre dalle ore 22:00 – Proiezione gratuita riservata ai soci AICS 2019/20